Author: Lisa Caramanno – 21/12/2018
Tra pochi mesi, precisamente nel febbraio del 2019, la rivoluzione iraniana del 1979, compirà quarant’anni, l’ultima grande rivoluzione del Novecento, quel “peccato originale” che ha mutato il volto, la storia e l’identità dell’Iran. L’Iran prerivoluzionario, le successive manifestazioni di massa, la fuga dello scià Mohammad Reza Pahlavi dall’Iran, il ritorno dell’ayatollah Ruhollah Khomeyni, l’instaurazione della Repubblica islamica e la guerra in Iraq sono state rivissute dal giornalista, ed esperto di Iran, Antonello Sacchetti nel suo ultimo libro dal titolo “Iran, 1979. La Rivoluzione, la Repubblica islamica, la guerra con l’Iraq”.

Un libro che si legge con la stessa emozione di chi, in patria o costretto all’esilio, ha vissuto quel lungo periodo del quale oggi ne rimangono i ricordi indelebili, e le testimonianze riportate in queste pagine così intense.
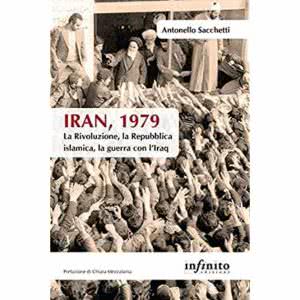
Già, allora, le compagnie petrolifere straniere furono costrette ad abbandonare la nazione, ed ora la storia sembra ripetersi in maniera quasi prepotente: la repubblica islamica deve nuovamente far fronte ad una difficile situazione dovuta, in primo luogo, alle recenti sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti guidato da Trump che sembrano relegarla all’isolamento internazionale.
Per cui Vision & Global Trends ha voluto capire i perché della rivoluzione iraniana del 79’, e di quegli eventi, attraverso una serie di domande rivolte all’autore del libro, Antonello Sacchetti che, da sempre, nutre un amore e una passione particolare per l’Iran di cui ha parlato, tra l’altro, in molti dei suoi libri.
Dalla lettura del suo libro sembra emergere che, per alcuni testimoni di quel periodo, il regime dello scià rappresentasse un freno alla crescita dell’Iran, un vestito molto stretto per un corpo che stava crescendo. Come stava crescendo, in quel periodo, l’Iran? e, a suo parere, di quale altro sistema avrebbe avuto bisogno per crescere, non solo nel senso economico-sociale delle riforme inaugurate con la Rivoluzione Bianca voluta dalla corte imperiale di Pahlavi?
A livello economico, l’Iran stava crescendo a un ritmo pazzesco: in quegli anni, il prodotto interno lordo registrava un andamento dell’8% + (medio annuo). La Rivoluzione bianca varata nel 1963 comportò dei cambiamenti profondi, soprattutto nelle campagne. La modernizzazione, imposta a tavolino dallo scià, non contemplava alcuna forma di apertura in senso democratico, di partecipazione attiva dei cittadini iraniani allo sviluppo del loro Paese. Mohammad Reza Pahlavi sognava un Iran moderno, tecnologicamente avanzato ma, al contempo, pretendeva di continuare a essere un sovrano assoluto, “il re dei re”, “la luce degli ariani”. Una contraddizione che, inevitabilmente, sarebbe presto esplosa. L’Iran non aveva una tradizione democratica e, quindi, il sovrano avrebbe dovuto ridurre il proprio potere. D’altro canto, la stessa Rivoluzione bianca era stata incoraggiata dall’amministrazione Kennedy come antidoto al comunismo. Gli sviluppi successivi, anche, all’interno dell’amministrazione statunitense, portarono a un irrigidimento del confronto della guerra fredda. Va ricordato che dopo il golpe anti Mossadeq del 1953 lo scià aveva creato un vero e proprio regime autoritario capace di reprimere le voci del dissenso servendosi, anche, della tortura.
Pertanto per crescere, anche, a livello politico, l’Iran avrebbe avuto bisogno di un sistema in grado di mettere in discussione le scelte dello scià ma ciò era, assolutamente, impensabile nell’ambito del quadro disegnato dalla corte imperiale e, probabilmente, anche in quello del suo alleato americano.
La presunta distanza tra lo scià e il popolo iraniano che porterà alla caduta del regime monarchico era da attribuire allo sfarzo imperiale allestito in quel periodo dal sovrano che, alcuni, hanno definito come uno spettacolo kitsch? È stata la reazione di un Iran che non voleva ammalarsi di “occidentosi” di cui parla Jalal Al-e-Ahmad nel suo libro intitolato “Gharbzadegi” dove, a proposito degli iraniani, scrive “siamo stranieri a noi stessi…” quasi a voler rivendicare una certa unicità dell’identità culturale del popolo iraniano?
Lo scià era cresciuto in un collegio svizzero, certamente era un uomo colto con una visione internazionale dei problemi. Da suo padre, Reza Pahlavi, aveva ereditato un’innata diffidenza nei confronti dei religiosi dei quali, però, si era servito in chiave anticomunista e, per il golpe del 1953, ma non era riuscito ad avvertire quanto fosse profondo il legame dei religiosi con il paese reale. E quest’ultima considerazione dimostra che la reazione di un Iran che non voleva ammalarsi di “occidentosi” non fu soltanto per lo sfarzo della corte o per la oscena celebrazione del 1971 a Persepoli per i 2.500 anni di monarchia.
Invece, riguardo a Jalal Al-e- Ahmad a cui lei fa riferimento, a proposito del suo libro intitolato “Gharbzadegi” con il quale critica la cd. occidentosi, quest’ultimo voleva significare che l’imposizione di uno stile di vita occidentale da parte del regime monarchico nei confronti di una cultura tradizionalista e antica come quella iraniana finiva per tramutarsi in delle soluzioni inadeguate.
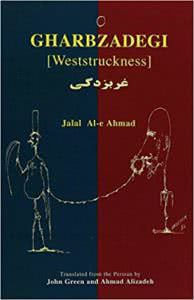
Ad esempio, la riforma agraria, imposta dallo scià, copiava il modello di sviluppo agricolo statunitense immesso, però, in una realtà, come quella iraniana, completamente diversa. Per cui, quello che funzionava negli Stati Uniti finì, invece, col produrre un disastro, in termini economici, in Iran: la qualità delle coltivazioni peggiorò, molte terre vennero abbandonate e tantissima manodopera venne espulsa dalle campagne andando a ingrossare il sottoproletariato urbano. D’altro canto, non si poteva rispondere ai dilemmi della modernità con le stesse risposte dei governanti dei paesi occidentali che avevano conosciuto uno sviluppo industriale completamente diverso. Governare il cambiamento, le trasformazioni degli anni Sessanta del XX secolo non fu facile per nessuno, ma lo scià si rivelò un leader poco lungimirante: da un lato predicava la modernità, dall’altro assumeva dei comportamenti degni di un monarca assoluto. In un’intervista concessa ad Alberto Moravia, a metà degli anni Settanta, parlava di sé come di un padre per tutti gli iraniani ritenendo traditori della Patria tutti coloro che dissentivano col governo dell’Iran.
Come va letta l’assoluta fiducia dell’alleato americano in un uomo come Pahlavi che, ad un certo punto, non aveva più il controllo del paese come dimostrato dalle proteste degli studenti iraniani verso lo scià durante il suo viaggio a Washington durante la presidenza Carter? Gli Stati Uniti avevano più paura del partito comunista iraniano o di un risveglio islamico?
Le proteste degli studenti iraniani davanti alla Casa Bianca furono, solamente, uno dei primi campanelli di allarme per la monarchia, abituata a simili episodi di contestazione. Il peggio doveva ancora arrivare, e arriverà in patria, con le manifestazioni via via sempre più imponenti, a partire dal gennaio del 1978. Ancora oggi colpisce il fatto che lo scià non abbia mai tentato un dialogo né con gli intellettuali filo-occidentali né con i religiosi. Per lui, chiunque criticasse la sua politica o invocasse riforme sociali veniva bollato come “reazionario nero o rosso”. La formazione di tipo occidentale dello scià non contemplava, infatti, alcuna reale accettazione della dialettica democratica. In questo, aveva perfettamente ragione Michel Foucault quando – alla vigilia della rivoluzione – sosteneva che in Iran fosse lo scià a essere vecchio, non Khomeyni: “Cinquant’anni, cento anni di ritardo porta il sogno un pò vecchiotto di aprire il suo Paese alla laicizzazione e alla industrializzazione. L’arcaismo oggi sta quindi nel suo progetto di modernizzazione, nelle sue armi di despota, nel suo sistema di corruzione. L’arcaismo è “il regime””.
Riguardo agli USA, quest’ultimi non avevano alcun timore del cosiddetto “risveglio islamico”, anzi, come dimostreranno in Afghanistan col sostegno ai mojahedin, hanno pensato, invece, di sfruttare l’islamismo politico in chiave anticomunista e antisovietica. D’altronde, va tenuto presente che il decennio conclusosi con la rivoluzione iraniana è stato segnato, fortemente, dallo sviluppo, un po’ in tutto il mondo, di movimenti rivoluzionari marxisti. Quindi, per Washington, il pericolo rimaneva quello “rosso”.
Arrivando alla vigilia della caduta del regime monarchico, fa effetto, tuttora, leggere quel “non provare niente” quell’ “Hich” del populista Khomeyni di ritorno in patria il 1° febbraio 1979. Bisogna interpretarlo come un gesto punk, un po’ nichilista o, in fondo, rispecchiava il suo programma rivoluzionario, apparentemente, dal carattere indefinito, senza un obiettivo chiaro che sembra essere stata la chiave del suo successo?
In realtà, Khomeyni aveva bene in mente il suo programma rivoluzionario visto che aveva definito il “Governo islamico” in un libro scritto, anni prima. Erano gli altri rivoluzionari ad avere le idee confuse. Khomeyni, con grande scaltrezza, si guardò bene dal dichiarare, apertamente, quali fossero i suoi reali obiettivi, quale fosse l’idea di Stato che aveva in mente. Il gesto di Khomeyni, quel “niente” quasi sputato in faccia al reporter occidentale è un gesto nichilista, così come in alcune fasi della rivoluzione ci sono fenomeni e comportamenti assolutamente nichilistici, quali le “ondate umane” con cui, durante la guerra, pasdaran e basij fronteggiavano il nemico iracheno.
Quindi si può parlare di successo per Khomeyni, perché alla fine è prevalsa la sua fazione, e si è realizzato il suo disegno politico. Per lui la Repubblica islamica rappresentava un progetto, invece per una parte dei suoi alleati, la repubblica islamica era, soltanto, uno slogan indefinito dai contenuti incerti. Khomeyni vince perché riesce a intercettare l’unica volontà comune di tutti i rivoluzionari, cioè cacciare lo scià. In questo è il più intransigente, il più netto di tutti. Se all’inizio del 1978 si parla di riforme della Costituzione, e poi di una eventuale abdicazione di Mohammad Reza Pahlavi, è solo dall’estate in poi che si parla di cacciare lo scià, e poi – in un secondo momento – di istituire una “Repubblica islamica”. Il repubblicanesimo in Iran non aveva una storia, una tradizione. È un concetto che la rivoluzione ingloba e promuove in tempi rapidissimi. L’islamizzazione della neonata repubblica avverrà molto velocemente, proprio perché il progetto di Khomeyni era strutturato e, perfettamente, in linea con la cultura tradizionale del Paese.
L’11 febbraio 1979 la rivoluzione non finisce ma entra in una fase diversa, più drammatica, violenta, per quale motivo, quali sono state le cause? Forse perché aveva vinto il ventre profondo della cultura islamica e di quella tribale sulla apparente modernizzazione dello scià?
Perché le anime della rivoluzione erano molto diverse tra loro, e perché non esisteva una cultura democratica del confronto. In questo, la fazione di Khomeyni non era diversa dalle altre. Un iraniano che partecipò alla rivoluzione lo spiega molto bene nel libro: “Noi non eravamo abituati a discutere, a confrontarci con chi aveva idee diverse dalle nostre. Il confronto politico era quasi sempre uno scontro, era la voglia di ‘rovinare la festa agli altri”. Lo scià, nel corso dei decenni, aveva fatto tabula rasa di tutte le opposizioni, a cominciare da quella più “moderata”, come il Fronte nazionale di Mossadeq. Quando lo stesso, alla fine del 1978, decise di dare la sua disponibilità per un compromesso, ormai era troppo tardi, perché non si trovavano più quel tipo di oppositori o gli stessi erano stati marginalizzati dagli estremisti. È la legge della politica: lo scià viene travolto dalla tempesta che lui stesso ha contribuito a fomentare in oltre trent’anni di potere assoluto.
Quale svolta è quella Khomeynista se squadre di seguaci militanti rivoluzionari aggrediscono le donne al grido di “o velo o botte”? E, oggi, la situazione non sembra tanto cambiata visto che si ha notizie di un governo attuale che cerca di limitare l’attivismo delle donne in favore dei loro diritti.
L’8 marzo è il momento dell’amaro risveglio per molti rivoluzionari e per tantissime donne, ma a colpire le manifestanti sono gli hezbollah, dunque una fazione dei rivoluzionari. Eppure, al referendum che si terrà tre settimane dopo, moltissime persone voteranno, in buona fede, per la “Repubblica islamica”, nonostante ci fossero segnali ben precisi circa la direzione che la rivoluzione stava imboccando. Va, anche, detto che sembra facile rileggere, oggi, quegli eventi col senno di poi: avvenne tutto nel giro di pochissimi mesi, e con esiti davvero inaspettati.
Con riferimento alla situazione attuale, va precisato che, in questi quarant’anni sono cambiate molte cose. La situazione di oggi non è paragonabile a quella dei primi anni della rivoluzione. La condizione femminile meriterebbe un approfondimento. Il codice civile penalizza, senz’altro, le donne ma con la Repubblica islamica ci sono stati dei cambiamenti che, invece, non si sono conseguiti sotto il regime dello scià. Oggi, infatti, la maggioranza degli studenti universitari sono donne, e in alcune facoltà, come quella di odontoiatria, si è reso necessario introdurre delle quote azzurre perché, altrimenti, ci sarebbero state quasi soltanto studentesse. Le donne iraniane lavorano, studiano e partecipano alla vita sociale, politica ed economica del Paese, ciò non toglie che ci siano, ancora, pesanti discriminazioni delle quali l’hejab obbligatorio è soltanto il più evidente e noto.
La cd. “guerra imposta” Iran-Iraq è stata l’ultima guerra convenzionale del XX secolo, l’ultima, cioè, a essere combattuta dagli eserciti di due Stati nazionali l’un contro l’altro armati. Una guerra terribile e poco ricordata in Occidente. In Iran è una ferita ancora aperta, celebrata dal potere e raccontata dal cinema come dalla letteratura. Perché ha sentito la necessità di raccontarla nel suo libro? Qual è il suo legame con la rivoluzione iraniana del 79’?
Perché senza la rivoluzione non ci sarebbe stata la guerra, perché Saddam Hussein non avrebbe mai attaccato l’Iran monarchico, e perché, senza la guerra, la rivoluzione avrebbe avuto, probabilmente, un corso diverso. Così come le rivoluzioni francese e russa, anche quella iraniana, una volta aggredita, si ricompatta. È una storia drammatica, terribile ma, assolutamente imprescindibile, per capire la rivoluzione oltre che la storia attuale dell’Iran. La guerra è il mito fondante della rivoluzione: i murales delle città iraniane omaggiano, quasi sempre, i martiri della guerra non quelli della rivolta contro lo scià.
Vorrei concludere con la toccante scena dal carattere cinematografico con cui si apre il suo libro, dell’autista del pullman Amir che sente il bisogno di ricordare il compleanno dell’ultimo scià di Persia. Come va letta questa nostalgia? come qualcosa di un passato che poteva essere e non è stato, o ‘è la nostalgia come sovversione’ di cui si parla in un reportage del ‘The Guardian’ del 2015 su Pahlavi per cui quest’ultimo sarebbe diventato una tela su cui dipingere una versione migliore dell’Iran?
Si tratta di un fenomeno di costume, una nostalgia per un’epoca che, nella maggior parte dei casi, non si conosce davvero, ma non c’è una base politica in quanto una restaurazione monarchica in Iran è, assolutamente, impensabile.
Per quanto riguarda il futuro politico del Paese, mi viene soltanto da raccomandare grande prudenza nelle previsioni. La Repubblica islamica ha dimostrato in questi quarant’anni una resilienza, assolutamente, imprevedibile. La stessa è stata data per spacciata tante volte, invece, questo sistema ha superato molti ostacoli ed è sopravvissuto a un passaggio epocale come la fine della Guerra Fredda che, direttamente o indirettamente, ha ridisegnato la mappa del Medio Oriente.
